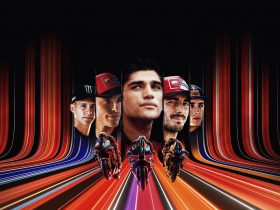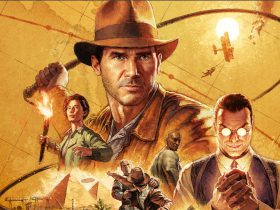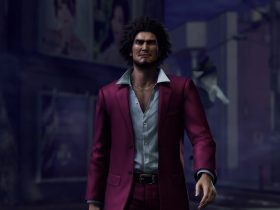Esiste un film di Damien Chazelle che abbia messo tutti d’accordo? D’istinto direi di no: nel suo modo di fare cinema, nella tendenza a raccontare le cose attraverso un filtro sempre più personale e trascendentale, in quel pensiero che a volte ci si debba soffermare più sull’idea che si nasconde dietro ogni scelta stilista che sulla sua riuscita comunicativa, si annidano i semi di un conflitto tra pareri di pubblico e critica, interni ed esterni, che va avanti ormai da anni. E nonostante ciò Chazelle è riuscito a diventare il piccolo pupillo di Hollywwod, guadagnandosi riconoscimenti e budget sempre più alti per i suoi progetti, fino ad arrivare all’ultimo Babylon, maestoso, costato tantissimo e già marchiato come un bel fallimento dalla stampa statunitense. Ed eccoci di nuovo qui, davanti al dilemma di sempre: chi non ha capito chi? Mettiamo subito in chiaro una cosa: Babylon ha molti pregi e altrettanti difetti, è magistrale nello stesso modo in cui è prolisso ed egoriferito, privo di ogni equilibrio. È quella tipologia di film che puoi capire e odiare allo stesso tempo, amare follemente e farti comunque mille domande confuse su cosa hai visto. È quello stimolo dissacrante che molti credono sia alla base stessa del concetto di arte e altri invece pensano sia un pretenzioso modo di nascondere un eccesso di superbia.
 Tre destini che si incrociano
Tre destini che si incrociano
Come spesso accade per i film di Chazelle, Babylon è la narrazione di un sogno. In questo caso si tratta di quello di Manuel (Diego Calva), Nellie LaRoy (Margot Robbie) e Jack Conrad (Brad Pitt), tre personaggi molto diversi tra loro, con in comune il bruciante desiderio di lasciare il proprio segno nel mondo attraverso il cinema. Siamo negli Anni ’20 e le cose sono ben diverse da come le conosciamo oggi: i set sono degli immensi agglomerati di caos e multitasking, dove nulla importa se non la resa estetica di una ripresa. Dialoghi, fotografia e sceneggiatura non hanno ancora stabilito la loro posizione nella struttura narrativa del mezzo. Questo però non impedisce alle persone di volerne fare disperatamente parte, in qualsiasi modo. Nellie, origini di provincia e un passato pieno di persone che le hanno ripetuto di essere brutta e grassa (scusate, ma parliamo della stessa Margot Robbie che conosco io?) sa di essere una star, anche se nessuno conosce nemmeno il suo nome, ed è disposta a tutto pur di mettere piede su quei set che ha sempre sognato, anche imbucarsi a una degenerata festa piena di deviati, ricchi e pretenziosi personaggi del cinema. È qui che conosce Manuel, che subito ribattezza Manny, e che, tra una sniffata di cocaina e un ballo selvaggio, circondati da ogni tipo di perversione ed eccesso, entrambi riescono a farsi notare e ottenere un’occasione per la realizzazione del sogno. Gli eventi che seguono questa pazza nottata sono la versione di Chazelle di una storia che già molti registi prima di lui hanno provato a raccontare, inserita però in un contesto storico e sociale differente. Il sogno, l’impegno, la fortuna, il caos, il delirio, il successo, il compromesso, la disperazione, il declino, la rincorsa, la speranza, la fine… non per forza in questo esatto ordine di apparizione. I protagonisti di Babylon attraversano tutte le fasi dell’evoluzione e involuzione del classico viaggio dell’eroe, dove la sua più grande nemesi è l’avvento del sonoro in un ambiente in cui la bellezza era sempre stata molto più importante di ogni parola.

Una lotta continua
C’è una cosa in cui Damien Chazelle è sempre stato bravo e che in Babylon raggiunge una delle più belle e impattanti dimostrazioni: la gestione dei contrasti. Questo film è narrativa dell’esagerazione in tutte le sue forme. Ci sono intere sequenze del film, prima fra tutte quella della festa iniziale, in cui il caos è il protagonista assoluto di tutto, con un numero impressionante di comparse in scena che si muovono secondo coreografie complesse e mai uguali a se stesse, mentre un impossibile pianosequenza le immortala nella loro depravazione eterna. Sullo schermo appaiono troppe cose per poterle seguire tutte, la mente dei personaggi è attraversata da troppi pensieri impossibili da focalizzare davvero, gli occhi sono abbagliati da una saturazione così vibrante da rendere tutto un ammasso caldo e luminoso, i suoni sono roboanti, con ritmi che si rincorrono e sovrappongo in continuazione. In questa prima immensa messa in scena, in regista crea una situazione in grado di frastornare lo spettatore, metterlo quasi sullo stesso livello di incomprensione lucida dei suoi protagonisti, preparandolo a quello che sarà il suo futuro (almeno per le successive tre ore). Ma così come esplode, Babylon è bravissimo anche a zittirsi, creando dei vuoti pneumatici improvvisi di silenzio assoluto e buio ben calcolato, di punti luce taglienti in una desolazione mentale e scenografica assoluta. Quando sei quasi sicuro di non poter reggere più la tensione sensoriale che ti si è costruita attorno, il film si spegne e ti lascia solo, a chiederti cosa sia appena successo.
 Forse troppo?
Forse troppo?
Esagerato, è questo l’aggettivo più consono per questo film. Una sensazione sicuramente voluta del regista che, attraverso gli eccessi di un mondo che conosce benissimo, nonostante sia cronologicamente distante dal suo, vuole lasciare la sua impronta nella rilettura dello stesso, già affrontata da molti altri registi prima di lui. Una scelta stilistica coraggiosa, in alcuni momenti anche assolutamente funzionale, ma che in altri rischia di prendere il sopravvento sul film stesso. Concentrati sulle derive psicologiche dei tre protagonisti, Babylon si perde per strada l’approfondimento delle storyline di personaggi altrettanto importanti e fondamentali come quella del trombettista Sidney Palmer (Jovan Adepo), della star asiatica Lady Fay Zhu (Li Jun Li), della giornalista Elinor St. John (Jean Smart) o dell’ennesima moglie di Jack, Estelle (Katherin Waterston). Attori straordinari per ruoli che hanno il compiuto di sottolineare le difficoltà razziali, sociali, economiche e ruolistiche di un mondo che non è solo dominato da attori e produttori, ma che non hanno abbastanza spazio per definire davvero se stessi, schiacciati dall’ossessivo disturbo del regista di aggiungere sempre più livelli alla sua cattedrale di eccessi. Chazelle ricorre a tutti i modi conosciuti per scioccare lo spettatore, per schiaffeggiare la sua mente che rischia di intorpidirsi davanti a un lavoro di una durata superiore alle tre ore, perdendo così l’occasione di dare davvero forza al suo messaggio, reso più esplicito che pressante. E tutto alla fine sembra ridursi in un grande ciclo, in cui tutto si rincorre all’infinito (anche alcune delle basi musicali, che richiamano nemmeno troppo silenziosamente qualcos’altro…) senza tregua e via d’uscita, dove ogni evoluzione viene abbattuta dalla sua involuzione e ogni scelta è già sbagliata prima ancora di essere presa.
È questo il modo di raccontare il cinema al cinema? Qualcuno potrebbe dire di sì, qualcun altro potrebbe preferire il linguaggio scelto da altri registi, anche molto recentemente. Sicuramente si tratta di un modo, molto personale e spiccatamente contemporaneo, a tratti incomprensibile e totalmente relegato ai meccanismi cognitivi della mente di Damien Chazelle. Ma quello che da un lato può essere visto come un eccellente tratto artistico, può essere allo stesso tempo letto come un caos non troppo ben gestito, ancora in via di sviluppo e raffazzonato, ambizioso ma che forse aveva bisogno di più tempo per essere rifinito al meglio.