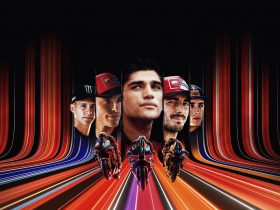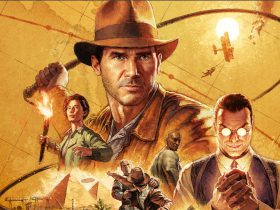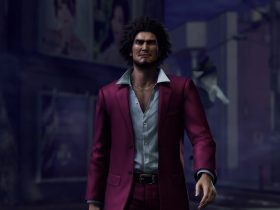Tutto quello che ci si poteva aspettare da Indiana Jones e il quadrante del destino, nato sotto l’egida Disney, il primo non diretto da Steven Spielberg (che resta produttore esecutivo) e lontano anche dall’apporto creativo di George Lucas, era un omaggio all’eroe che fungesse da addio alle armi per Harrison Ford nel suo ruolo più iconico e da avvio per nuove iterazioni del franchise.
Una bella gatta da pelare per il nuovo regista James Mangold, perché è abbastanza chiaro che il pubblico non riesce a immaginare un Indy con un volto diverso – ma ha la memoria corta, perché il personaggio è stato più volte interpretato da altri validissimi attori, sebbene usando l’espediente di altre età e fasi della vita: da Corey Carrier, Sean Patrick Flannery e George Hall che gli hanno prestato corpo e voce nel telefilm Le avventure del giovane Indiana Jones al leggendario River Phoenix che ha convinto tutti con il suo Indiana tredicenne nel prologo de L’ultima crociata – e tantomeno un “erede”, visto quanto ha odiato il tentativo con il Mutt Williams/Shia LaBeouf de Il regno del teschio di cristallo.
 Indiana Jones e il quadrante del destino: muoversi nello spazio tra gli spazi
Indiana Jones e il quadrante del destino: muoversi nello spazio tra gli spazi
Film, Il teschio di cristallo, ingiustamente sottovalutato, che sotto un’estetica forse un po’ troppo sospinta dalla cgi e una sceneggiatura che lasciava molto spazio all’immaginazione, nascondeva comunque un tesoro di comparto teorico che solo un’accoppiata come quella Spielberg/Lucas avrebbe potuto concepire: dalla bomba atomica come nuova arca che scioglie i volti dei manichini come si scioglievano quelli dei nazisti alla fine de I predatori…, all’arrivo in scena, in contesto di esperimenti atomici, di un certo ‘generale Ross’, che non può che far pensare a un riferimento a Hulk e alla bomba gamma che lo trasforma nel mostro, ironicamente quindici anni prima che Ford fosse scritturato dalla Marvel proprio per il ruolo di Ross, e ancora gli esseri interdimensionali che si muovono “nello spazio tra gli spazi” (ovvero, i fotogrammi della pellicola) e il frigorifero – concetto originario di macchina del tempo per Ritorno al Futuro, prima della De Lorean, suggerito a Zemeckis proprio da Spielberg – che idealmente trasporta Indy dagli anni ’30 agli anni ’50, modello che, non a caso, negli USA era pubblicizzato come “a prova di bomba”.
Eppure Il teschio fu odiato, forse non capito, forse troppo raffinato per un cinema che già cominciava ad assaporare il gusto della serialità e degli universi condivisi, spesso a costo di sacrificare una scrittura offerente più livelli di lettura rispetto al semplice entertainment.

Indiana Jones e il tempo maledetto
Così Mangold – onestissimo regista, ma probabilmente più adatto a un cinema riflessivo e poco a suo agio col ritmo frizzante e i guizzi concettuali che dovrebbero confarsi a un film di Indiana Jones – si è trovato sulle spalle anche il peso di dover “cancellare” il teschio dalla memoria degli spettatori, che spesso cadono nella contraddizione in termini che li vede sospesi tra una puerile forma di negazionismo – “Il teschio di cristallo non esiste!” – e il paradosso, proprio affermando questo, di dargli fin troppa importanza.
Non sarebbe stato difficile, con Indy: una delle caratteristiche più affascinanti delle sue avventure è stata sempre quella di restare fruibili e godibili indipendentemente le une dalle altre, tanto da potersi permettere vezzi come il collocare il secondo film della serie, temporalmente, un anno prima del precedente (tipico di Lucas, pensiamo anche a Star Wars e all’ordine simpaticamente sballato delle sue trilogie). Insomma, quella di Indy non è propriamente una “saga”, ma piuttosto una serie di godibili esperienze accomunate dal medesimo protagonista.
Non piace il teschio? Bastava non parlarne. Indiana Jones e il quadrante del destino, invece, cade proprio nella contraddizione di cui sopra, e diventa un film fortemente “teschiocentrico”, il che gli conferisce anche un poco gradibile flavour alla ‘Cane Poochie’ dei Simpson (e non andiamo oltre per non spoilerare, ma chi ha orecchie per intendere “in tenda”, come un vero esploratore avventuriero).
E vuoi o non vuoi, in questo concetto di spostamento temporale, Il teschio lo segue e lo scimmiotta anche – il che è ironico, se pensiamo che un’altra delle scene più controverse di quel film riguardava delle scimmie – ma in maniera più volgare e meno didascalica.
Il tempo, comunque, è uno dei temi chiave: il tempo che passa per Indy, e lo costringe a una vita da anziano ordinaria e priva di brividi. Nessuna studentessa gli fa più gli occhi dolci – eppure, in maniera un po’ contraddittoria, Mangold ce lo mostra subito a torso nudo, sottolineando che il fisico ce l’ha ancora – nessuno viene più a chiamarlo per mettersi alla caccia di un tesoro nascosto. Schiacciato dalla noia e dalla depressione per il matrimonio fallito con Marion, Indy (ma ormai tutti lo chiamano Henry) è un vecchietto rompiscatole che bussa alla porta dei “capelloni” – siamo nel 1969, giorno dell’allunaggio – perché fanno rumore con la loro musica.
Per un fan a tutto tondo, non è nemmeno una cosa negativa, perché il suo atteggiamento qui ricorda non poco proprio quello che aveva l’Indy ottuagenario degli anni ’90 interpretato, nel telefilm di cui sopra, da George Hall (e poco importa che ormai sia considerato fuori canone).
Poi però irrompe nella sua vita Helena, figlia di un suo vecchio amico – che ci hanno presentato nel prologo, dove come è noto Ford è ringiovanito, con effetto tutto sommato abbastanza convincente. Già che ci siamo: non è il logo Paramount a sfumare nella prima inquadratura ma quello Lucasfilm, questioni di importanze – che lo riporta sulle tracce della macchina di Antikythera, ingranaggio costruito da Archimede che permette di individuare delle “fessure” nel tessuto spazio temporale per poter viaggiare tra i secoli.
Un gruppo di nostalgici nazisti, capeggiati da Jurgen Voller (Mads Mikkelsen) la vuole usare per tornare nel passato, correggere gli errori e vincere la guerra. Helena, più cinicamente, la vuole vendere per pagare dei debiti. Indy nemmeno ci crede troppo ma… e qui è il problema … finirà per volerla usare per scopi ancora meno nobili.
 Indy, sei tu?
Indy, sei tu?
E siamo arrivati a uno dei problemi principali del film. Al di là dell’evidente difficoltà di Mangold ad adattarsi alla materia – e forse dobbiamo cominciare ad accettare che, più che Indiana Jones, ci piaceva il modo in cui Spielberg & Lucas lo raccontavano in un certo contesto storico – per cui tutto sommato non fa altro che riproporre trovate già viste nei precedenti capitoli – il treno in corsa, il sidecar, il volo dall’aereo, il cunicolo pieno di insetti – tanto per ribadire a tutti che siamo di nuovo a casa (Ciube), e a volte anche concedersi variazioni fuori luogo, come un evitabile flashback sistemato al posto dell’iconica “mappa con tracciato rosso” durante il primo spostamento di Indy.
Al di là di troppe facilonerie di sceneggiatura – reperti archeologici segretissimi con un’etichetta in evidenza che ne indica il contenuto, nazisti che sanno di stare inseguendo una spia in divisa e non si prendono cura di controllare se si è mimetizzata tra i commilitoni, un potenziale assassino, ricercato con tanto di identikit, che prende un aereo come se nulla fosse – la cosa che più lascia di stucco è il comportamento di Indiana, totalmente irrazionale, che gli fa perdere quella che dovrebbe essere uno dei tratti più forti del personaggio: restare un saldo baluardo a difesa della ragione contro l’irrazionalità e il fanatismo, di bandiera nazi, comunista o thuggee che sia.
 E adesso?
E adesso?
Altro problema del film è quello di lasciar intendere, evidentemente, con l’ennesimo finale “aperto”, che Disney non ha ancora capito cosa fare col franchise. Anche qui non parliamo esplicitamente, però è come se si tornasse allo status quo dichiarato alla fine del Teschio di Cristallo. Se è vero – nonostante le smentite di Mangold – che ci sono stati degli screen test non soddisfacenti con ben cinque finali proposti, dei quali nessuno è piaciuto al pubblico, o se è vero anche solamente che sono stati girati cinque finali, allora capiamo anche perché il finale scelto sembri un po’ appiccicato con la gomma americana, con l’avvento del classico Deus ex Machina che risolve una situazione di sostanziale incartamento.
È anche il momento in cui Helena la fa da padrone, con tutta l’ansia che c’è oggi di dimostrare che esistono personaggi femminili tosti – ma perché, non lo era già Marion Ravenwood nell’81, che riusciva a liberarsi da sola dal giogo del villain con la sua spregiudicatezza e il potere della seduzione? – e poi qualche citazione nostalgica (con tanto di reprise musicale. A proposito, la soundtrack di Williams è buona) che male non farebbe, se per il resto ci fosse più accuratezza e sostanza.
Il film ha ricevuto critiche miste dopo l’anteprima al Festival di Cannes, le proiezioni parlano di un disastro al box office (che comunque non gli auguriamo), il fattore “eredità” con Indy non funziona e Ford è comunque troppo vecchio per farne altri. Le prospettive che possiamo immaginare sono diverse: da un lato c’è questo fattore deaging che diventa sempre più preponderante, anche se la produttrice Kathleen Kennedy ha dichiarato in un’intervista (dobbiamo crederci?) che “non è quello il futuro”.
È chiaro che bisogna svicolare. S’era parlato di una serie con protagonista Abner Ravenwood, mentore di Indy, ma è stata annullata. Un prodotto d’animazione – filmico o seriale – con Ford a dare la voce al protagonista non sarebbe male.
Il recast potrebbe funzionare se fosse molto evidente che il nuovo Indy si trova in una differente fascia d’età (come del resto fatto negli anni ’90), magari proprio nell’epoca in cui era allievo di Abner. Oppure, ci si potrebbe giocare una carta d’oro, quella dell’unica “legacy” che forse i fan di vecchia data potrebbero considerare interessante. Facendo due più due: Ke Huy Quan, mitica spalla di Indiana ne Il tempio maledetto, dopo anni di anonimato, ha recentemente vinto un Oscar per la sua prova d’attore in Everything, Everywhere, all at Once… e si è detto disponibile a tornare in sella nel caso di una chiamata. Noi lo diciamo, nel caso, ricordatevene: lo spin-off The Adventures of Short Round potrebbe essere dietro l’angolo.
Certo, questo Indy è avanti con gli anni, ha sofferto, non è più in forze, ma questo non giustifica che compia o voglia compiere, per un tornaconto personale, azioni stupide o pericolose per l’intero genere umano. Non è nel personaggio (come non lo era, se vogliamo, il comportamento del Capitan America di Avengers Endgame, che si rifugia nel passato con il suo amore di gioventù restando probabilmente in silenzio mentre avvengono i più atroci crimini come l’attentato alle Torri Gemelle).
Non vogliamo spoilerare, ma abbiamo fatto veramente fatica a riconoscere l’Indy che abbiamo sostenuto e amato, e siamo abbastanza convinti che lo “split” tra Spielberg e Disney – al di là delle affermazioni “di circostanza”, comprensibili – abbia a che fare con questa svolta. Come se non bastasse, a nostro parere il film rompe del tutto il delicato equilibrio tipico delle Jonesesche avventure, tra elementi storici e “realistici” e brevissime incursioni nel fantastico, esagerando in termini di richiesta della sospensione dell’incredulità. Purtroppo è anche un film – sebbene tecnicamente corretto – privo di guizzi visivi o trovate veramente originali.