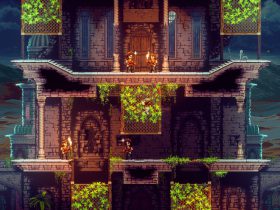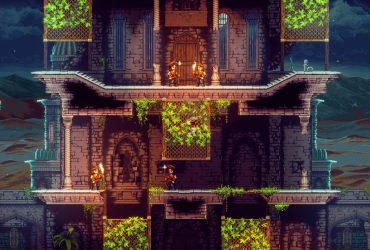Se Dirty Harry avesse ottant’anni (e Clint Eastwood quasi li ha) sarebbe così, un rabbioso vecchiaccio che ce l’ha col mondo, solo nella sua ben tenuta casetta nella periferia di Detroit, solo col su
Cast: Clint Eastwood, Bee Vang
Distribuzione: Warner
Voto: 65
Se Dirty Harry avesse ottant’anni (e Clint Eastwood quasi li ha) sarebbe così, un rabbioso vecchiaccio che ce l’ha col mondo, solo nella sua ben tenuta casetta nella periferia di Detroit, solo col suo cane dopo la recente morte della moglie, assediato da un’estranea comunità multirazziale che detesta profondamente.
E ne ha ben donde, in quanto i vicini tengono male la casa e il prato, seguono strane usanze, mangiano strane cose e lo guardano storto (come fa del resto lui). Per di più lungo le strade scorrazzano in auto tamarre gang di vario colore, latini, orientali e neri. Per tutti Walt Kovalski ha l’adeguato nomignolo spregiativo, per tutti tiene pronto in una cassapanca un piccola arsenale ben oliato. Non frequenta nemmeno i figli, estranei da sempre, né i nipoti che detesta, cordialmente ricambiato: un uomo che quanto a malanimo fa a gara col protagonista de La 25a ora, con la sua famosa invettiva. In più Walt è vecchio, deluso e isolato e intravede nel fondo delle latine di birra i primi bagliori della “grande luce”.
Il fulcro della sua vita è la sua splendente Gran Torino, una vecchia bellissima Ford del ’72, di quelle che costruiva quando lavorava con orgoglio in fabbrica, dopo aver servito il suo paese nella Guerra in Corea, che quotidianamente lucida e spolvera con sacro rispetto, un simulacro di un tempo, di un paese, di una vita che non ci sono più. La macchina sarà il motore di tutta la storia: Thao, complessato adolescente della casa accanto, di stirpe Hmong (un’etnia dell’Indocina), cerca di rubarla come prova di iniziazione per entrare in una gang, costretto a forza ad un’azione che non fa parte della sua natura gentile e pacifica. Entrato in contatto con una realtà che scopre ben diversa, Walt poco alla volta constata che i vicini sono bravissime persone e, grazie soprattutto a Sue, volitiva sorella di Thao, si avvicina alla comunità straniera molto più che ai suoi concittadini o al resto della sua famiglia. Ma il sogno di una convivenza pacifica si infrangerà sul pregiudizio e sull’ignoranza di altri, ben peggiori di lui, sancendo che la situazione è senza uscita. Una soluzione si potrà trovare, estrema, a fare piazza pulita di rimorsi, rancori, fallimenti.
Oltre alle riflessioni sul senso di identità perduto (sia da parte di Walt sia da parte degli Hmong), si allude al gap fra generazioni, alla mancanza di veri rapporti umani, sia in famiglia sia tra amici, tutto superficiale o improntato sull’interesse. Nell’ottica violenta e aggressiva tipica di quel tipo di “americano medio”, il praticello diventa il “proprio” territorio da difendere anche col fucile spianato, ultimo lembo di una proprietà che si vede sempre più assediata e destabilizzata, con lo spirito segnati dai traumi della guerra che non passano mai, un inefficace rapporto con la religione e l’interrogativo ultimo: in che cosa consista davvero “essere un uomo”. Il protagonista si trasforma, durante la narrazione, in un bisbetico domato, un aggressivo che diventa bonario, un John Wayne pentito che porta ancora nell’anima le ferite di quando ha ammazzato molti di quei “musi gialli” dei quali adesso apprezza perfino la cucina, ricalcando il cliché del vecchio burbero dal cuore d’oro, nel quale l’incomprensione verso i diversi diventa, attraverso la conoscenza, accettazione e tolleranza. Nella sua scelta finale ribalta la morale declamata in precedenza, lanciando un messaggio positivo ad un paese che deve fare quotidianamente i conti con la “diversità” di milioni di persone, con usi e costumi e accenti sempre più diversi (l’infermiera indiana, la dottoressa cinese).
Di maniera però il percorso che avvicinerà il vecchio al ragazzo, causando in entrambi una modificazione determinante, scontata la lezione di vita che l’adulto impartisce al giovane bisognoso di un punto di riferimento maschile, mentre divertente e sagace è il veloce e sarcastico breviario delle “cattive” maniere di comportarsi del “maschio medio”, impartito a Thao da Walt e dal suo barbiere di origine italiana. Ma sembra davvero che un paese così non sia né per vecchi, né per giovani. Il film si poggia interamente sul grande vecchio Eastwood, che in simbiosi col suo personaggio esibisce senza problemi tutta la sua rugosa e durissima faccia, soprattutto nella prima parte, facendo lampeggiare il collerico sguardo azzurro, con smorfie e ghigni memorabili. La storia ha più sfumature di lettura, naturalmente da un autore come Eastwood ci aspettiamo sempre discorsi non superficiali: l’integrazione totale resta un sogno, troppo forti saranno sempre i violenti irriducibili di qualunque colore. Ma ringhiarsi addosso reciprocamente, discriminando e disprezzando, sarà sempre una strada senza uscita. Se parliamo di personaggi costretti a rivedere drasticamente il proprio credo, allora molto più sofferta era la parabola che portava alla “redenzione” di un altro personaggio tutto d’un pezzo, il Tommy Lee Jones di Nella valle di Elah, senza contare il civilissimo percorso di dolorosa accettazione che era costretto ad autoinfliggersi il protagonista de L’ospite inatteso.