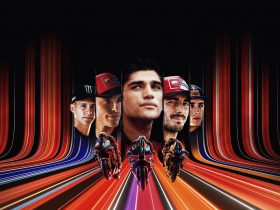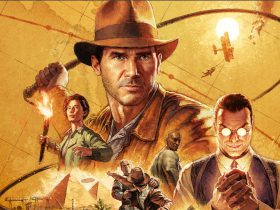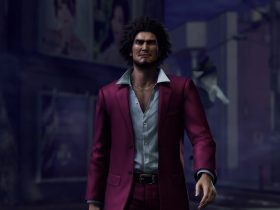Conosciamo meglio la storia degli Stati Uniti, che la nostra, così come siamo più informati sulla Rivoluzione francese o su vari passaggi storici della Gran Bretagna.
 Regia: Mario Martone
Regia: Mario Martone
Cast: Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi, Luca Zingaretti, Toni Servillo
Distribuzione: 01 Distribution
Conosciamo meglio la storia degli Stati Uniti, che la nostra, così come siamo più informati sulla Rivoluzione francese o su vari passaggi storici della Gran Bretagna. Questo perché il cinema, sottovalutato vettore di apprendimento, all’estero ha trattato con senso dello spettacolo eventi che studiati sul piatto foglio di carta ci avrebbero fatto sbadigliare, mentre, incarnati nelle appassionanti vicende di personaggi storici o di finzione, ci hanno non solo tenuti svegli ma si sono impressi nel nostro bagaglio culturale. Possibile che conosciamo e apprezziamo le lotte di indipendenza scozzesi e irlandesi per sottrarsi al giogo inglese e quelle dei coloni americani contro francesi e inglesi e poi indiani meglio delle nostre? Sono pagine ignorate, perché poco raccontate in famiglia, e male approfondite a scuola. Forse che le nostre vicissitudini storiche si differenziano tanto da quelle straniere da renderle di difficile spettacolarizzazione? Perché i nostri eroi sono poco appassionanti? È colpa della storia o di chi la racconta? Eppure si tratta sempre di temi universali, ideali per i quali morire, tragiche storie d’amore, lutti e morti dolorose, sacrifici e rinunce (sempre viene da chiedersi se ne valesse la pena). Nel nostro felice paese, alcuni tentativi, in forma di romanzo o di film realizzati nel passato, sono stati regolarmente accusati di faziosità, da una o dall’altra parte, non incoraggiando di conseguenza la popolazione a stringersi unita intorno ad un’identità percepita come comune: identità che non c’è mai stata né mai ci sarà nemmeno in futuro, visti i tempi che corrono. Con Noi credevamo il regista Mario Martone tenta un’operazione azzardata, divulgare, spettacolarizzandolo, il tema ancora oggi tanto controverso dell’Unità d’Italia, a ridosso dei festeggiamenti per il cento cinquantenario, forse in risposta al revisionismo attuale che vede nell’unione del Nord con Sud una sciagura. Non dimentichiamo che la base del revisionismo storico è l’affermazione che chi scrive la storia lo fa attraverso il punto di vista del vincitore, senza tenere conto delle ragioni dei vinti (come si diceva in Braveheart: a scrivere la storia sono gli stessi che hanno impiccato degli eroi). Dipende sempre dai punti di vista: eroi o banditi, patrioti o terroristi? Tre ragazzi del Sud sono i protagonisti, ispirati a personaggi realmente esistiti, raccontati da Anna Banti nel suo romanzo omonimo. Martone, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Giancarlo De Cataldo (Romanzo criminale), percorre circa trent’anni di storia, dal 1828 al 1862, a partire dalla feroce repressione borbonica dei moti rivoluzionari del 1828, che provoca la decisione dei tre amici di affiliarsi all’associazione insurrezionale costituita all’estero da Giuseppe Mazzini, già in esilio. Sono gli anni dei carbonari, della Giovine Italia, di Cavour, di Pisacane e di Garibaldi. E sono sempre gli anni di repressioni, esili, torture, tradimenti, esecuzioni. Le strade dei tre amici, Domenico, Angelo e Salvatore, tutti della zona del Cilento, due di nobile origine, contadino il terzo, si divideranno, portandoli in direzioni diverse, incarnando tre diversi modi di vivere i propri ideali nel flusso inarrestabile della storia. Nelle loro vite condannate all’esilio, senza affetti, proveranno carcere, morte, solitudine, insidie di ogni tipo. La narrazione, suddivisa in quattro capitoli, traccia un affresco cupo e tragico, dove risalta soprattutto l’invincibile incapacità nostrana di aderire ad un progetto unitario, sorvolando sulle divisioni interne in nome di un ideale condiviso. Qui l’ideale dell’Unità d’Italia è sì condiviso, ma visto da monarchici e repubblicani in modi diametralmente opposti, al di là del comune desiderio di affrancarsi dagli oppressori stranieri, con un’insanabile divisione fra ricchi e poveri, fra nobili e popolani, e sempre fra gente del nord e “sudisti”. Il quadro è quello di un paese perennemente diviso, grazie ad una genetica propensione all’individualismo che alimenta una sotterranea, perenne atmosfera da guerra civile. Se le radici dell’albero piantato sono malate, nasceranno frutti malati, una nazione di sudditi e non di cittadini. Il film distribuito in sala dura ben 170 minuti, troppi, avrebbe necessitato di diversi tagli per rendere alcune parti più agili. In questo modo la narrazione soffre per un’eccessiva frantumazione delle azioni in una sequela di scene che scorrono a tratti senza fluidità. Al Festival di Venezia era stata presentata una versione di 204 minuti, che sarà trasmessa a puntate in televisione. Formalmente, sono pregevoli le interpretazioni di un cast enorme, così come la cura calligrafica nella ricostruzione ambientale (anche se i villici di Baarìa erano più realistici, vestiti di abiti sdruciti e muniti di dentature sconnesse), nella quale spicca un passaggio in cui due personaggi riparano sotto una volta in cemento armato, sulla quale sorge un edificio semi-costruito, con tanto di tondini che sbucano dai soffitti, come spesso si usa nel meridione, con un intento che forse dovrebbe essere chiesto al regista stesso. Per concludere citiamo le parole di Cristina Trivulzio, principessa di Belgiojoso, sempre tristemente attuali: è inutile dare la libertà al popolo, se non viene educato a usarla.
A cura di Giuliana Molteni