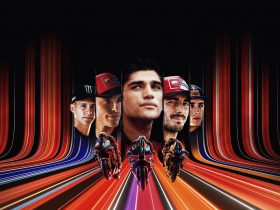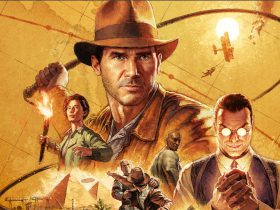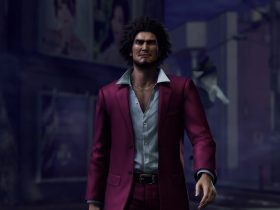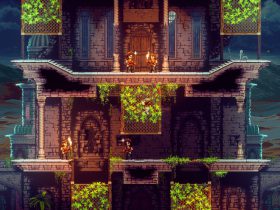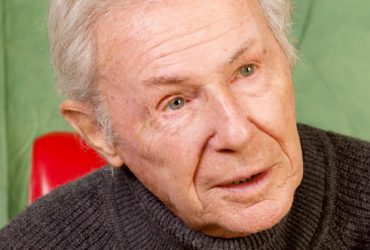Caro Ridley Scott,
grazie: per aver diretto nel 1982 con non quantificabile abilità Blade Runner: un film così immenso che non si è fatto amare fin da subito e che solo per merito della Director’s Cut del 1991 si è lasciato davvero apprezzare. Ma un ringraziamento più contingente ti è dovuto, caro Ridley, per esserti dedicato negli ultimi anni a un’altra franchise di fantascienza che sempre dal tuo genio ha preso vita: Alien. Perché se ti fossi (legittimamente) incaponito a riprendere possesso di Blade Runner come hai fatto per Alien – a quest’ora staremmo parlando di un altro film, di un diverso anno del Signore 2049, di un’altra storia. E invece grazie, ancora, per aver lasciato – almeno stavolta – la regia ai giovani, a Denis Villeneuve. Non che Blade Runner 2049 sia venuto perfetto com’era lecito sperare, del resto non lo è l’originale. E comunque non è il caso di fare paragoni in termini di qualità. Non è possibile. Nel 1982 tutto era nuovo: dopo di te, Ridley, niente è stato più lo stesso. Blade Runner ha messo in immagini ciò che prima era stato parole, un futuro dove la distopia consiste nell’eccesso di informazioni, piuttosto che nell’assenza, un mondo così bello da vedere quanto brutto dev’essere viverci. Rifarlo, a più di trent’anni di distanza, era impossibile, di più, follia.
Perciò ci voleva coraggio, un pizzico di follia e grande amore per il materiale originale. E Blade Runner 2049 ha certamente molto rispetto per il primo film. Lo dimostra dai primi minuti: androidi che sfondano muri, la noia dei viaggi nelle auto volanti, le indagini dell’Agente K (Ryan Gosling) attraverso gli iconici ingrandimenti d’immagine che hanno caratterizzato la ricerca di Deckard, e in generale un vago e onnipresente senso d’impotenza nei confronti della torbida realtà. L’incessante pioggia (presumibilmente acida) c’è ancora, naturalmente. Ryan Gosling è un protagonista molto diverso da Harrison Ford, benché sia anche lui un dotato blade runner, ma è un perfetto eroe tragico e, anzi, ho capito finalmente in cosa consiste la sua bravura di attore: non nel mostrare, ma nel reprimere emozioni. Il film ce lo presenta già in missione, a caccia di un replicante interpretato da (un bravissimo) Dave Bautista. La scena pare presa direttamente dal Manuale del perfetto sci-fi noir: e non è nemmeno ambientata in un’oscura città.
L’Agente K è un tipo solitario, così solitario che le uniche persone che vede sono il suo capo Madame (Robin Wright) e la sua olo-fidanzata Joy (Ana De Armas). Ed è proprio con quest’ultimo personaggio che il film tenta davvero d’aggiungere qualcosa alla mitologia, vale a dire con un’intelligenza artificiale che – ci viene suggerito – è capace di provare emozioni. “More human than human” è una delle indimenticabili frasi del primo film, la cui vicenda è messa in moto dalla disperata vitalità di esseri sintetici. Gli umani di Blade Runner 2049 sono ancora gli stessi patetici individui che conosciamo, disposti a campare come formiche mentre i potenti vivono in moderne, maestose ziggurat, consapevoli e inorriditi dal fatto che una nuova, migliore specie stia prendendo il sopravvento. La pellicola di Villeneuve è certamente un diesel, ed esprime tutto il suo potenziale solo con l’arrivo di Harrison Ford, in una delle sue migliori interpretazioni.
Dove il film pecca, invece, è nel delineare il più tremendo di questi umani, il villain Niander Wallace (Jared Leto): poco più che un cliché, che affida al solito monologo il suo perfido piano. È qui che Blade Runner 2049 soffre di più il confronto con l’originale: cede alla tentazione di spiegare le conseguenze delle azioni, le implicazioni dello scontro cui assistiamo, quando il cult del 1982 lasciava tutto al sottotesto e all’ambientazione claustrofobica. Però è davvero bello, il film: di Denis Villeneuve ci si può fidare ormai. Le musiche di Benjamin Wallfisch e Hans Zimmer sono un po’ intrusive ma comunque potenti, la fotografia del maestro Deakins così bella che ti scordi che c’è.