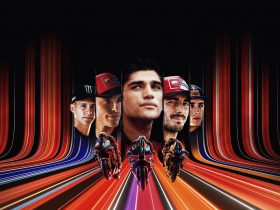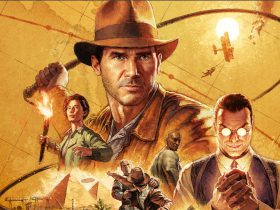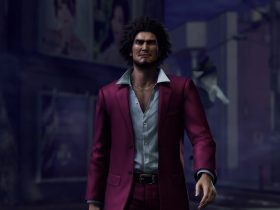19XX, interno sera. Due ragazzini sono seduti sull’ampio tappeto di una cameretta, intenti a fissare sbalorditi l’unica fonte di luce della stanza: un televisore di modeste dimensioni incastonato nel penultimo ripiano della libreria, che riproduce le fattezze sgranate di tre astronauti apparentemente dispersi sulla superficie di un pianeta roccioso. “Sei sicuro?”, chiede il primo dei due attoniti spettatori. “Vogliamo controllare?”. In tutta risposta, il secondo afferra una rivista e inizia a sfogliarla con impazienza, seguendo poi il testo di una delle pagine centrali con il dito. “Dovevamo prendere l’altra chiave nella Faccia di Marte…”, asserisce dopo qualche istante, con un tono a metà fra il drammatico e il remissivo. “quella piccola.”
“E non possiamo tornare indietro?”
Aggrappati ad un esile filo di speranza, entrambi passano in rassegna l’inventario, ma non c’è traccia dei biglietti necessari per attivare la monorotaia che aveva trasportato i cosmonauti nella nuova schermata.
“No, ne avevamo presi solo tre, e questo monolite è rotto. Siamo bloccati…”
Era un’epoca in cui la scienza del salvataggio multiplo si trovava ancora al di fuori della nostra portata ed i giochi non agonistici, o perlomeno quelli non in mio possesso, dovevano essere obbligatoriamente completati nell’arco di tempo che andava dal termine della messa domenicale a poco prima dell’ora di cena, esclusi i minuti rubati da pranzo e merenda. Dunque, non rimase altro da fare che pigiare con mestizia l’interruttore laterale del Commodore 64 e riflettere su quanto la nostra sconsideratezza avesse impedito a Zak, Annie, Leslie e Melissa di sventare i malefici intenti dei Caponiani. Insomma, il debutto nel mondo delle avventure grafiche fu abbastanza disastroso per il sottoscritto e, se mi fossi lasciato sopraffare dallo scoramento per la fallita risoluzione di Zak McKracken and the Alien Mindbenders, probabilmente avrei concluso che non faceva proprio per me: invece ho perseverato e sono riuscito ad affrontare bestie ben peggiori come i baffi di Gabriel Knight, lo scheletro della tartaruga aliena di The Dig, il circolo di pietre di Riven o la detestabile capra di Broken Sword, confronto alle quali l’intransigenza dei primi esperimenti di Lucasfilm Games nel genere appare come semplice conseguenza della loro relativa immaturità. L’ascesa di Ron Gilbert e della sua filosofia assolutamente contraria alla penalizzazione del giocatore, il quale anzi doveva essere in qualche modo ricompensato nel caso in cui si fosse spinto oltre i confini tracciati dalla sceneggiatura, fu accolto come una vera rivoluzione e rappresentò un punto di svolta nel design dei tradizionali titoli punta e clicca: il prolifico autore originario dell’Oregon capovolse in tal modo le convenzioni di questi ultimi come già riuscì a fare con l’introduzione dello SCUMM, il motore grafico pensato per il suddetto Maniac Mansion, che svincolò definitivamente questa specifica tipologia di giochi dai comandi testuali. Dopo la consacrazione definitiva avvenuta con i primi due capitoli della saga di Monkey Island, Gilbert si destreggia fra vari progetti con alterne fortune finché, nel 2014, torna ad incrociare il suo percorso creativo e professionale con Gary Winnick, l’artista con il quale diede il via all’epoca d’oro delle avventure prodotte dalla casa editrice fondata da George Lucas, ed entrambi inaugurano un nuovo progetto che, sotto la neonata etichetta Terrible Toybox e con il contributo finanziario dei migliaia di entusiasti accorsi in massa per supportarne il Kickstarter, si propone di riportare finalmente in auge un mondo fatto di atmosfere retro-cubettose, personaggi bislacchi, meta-narrativa e interazione a base di verbi da combinare con oggetti o soggetti direttamente a schermo. Benvenuti a Thimbleweed Park, una (invero ben poco) ridente cittadina immersa in un perenne crepuscolo, fra le cui strade si aggirano due detective giunti sul posto per occuparsi di un efferato delitto, una talentuosa programmatrice che sogna una carriera nel mondo dell’intrattenimento videoludico a scapito degli interessi della propria famiglia, uno sfortunato agente di commercio andato incontro ad una fine prematura che tenta di risolvere alcune questioni lasciate in sospeso, ed un clown divenuto celebre grazie alla sua proverbiale sfrontatezza, ma ridotto ormai sul lastrico da un’impietosa maledizione. Eppure, nonostante la tragicomicità delle vicende che li vedono coinvolti, quanto sta accadendo davvero sotto la sonnolenta facciata del piccolo borgo ha una connotazione ancora più sinistra…

I SEGNALI SONO MOLTO FORTI, QUESTA NOTTE
La coppia di sviluppatori non ha nemmeno provato a nascondere i molteplici riferimenti ad un certo tipo di cultura pop molto in voga all’inizio dell’ultimo decennio dello scorso secolo, in particolar modo quelli rivolti a X-Files e Twin Peaks, che trasudano da ogni pixel: il titolo si apre infatti con il più classico degli omicidi senza causa apparente, e la coppia di agenti federali formata dalla sarcastica veterana Angela Ray e dall’inesperto ma affascinante (almeno, a detta di molte delle rappresentanti del gentil sesso che popolano il villaggio) Antonio Reyes, le cui dinamiche ricordano molto da vicino quelle dei ben più rinomati Fox Mulder e Dana Scully, viene incaricata delle indagini. Gli altri personaggi menzionati, ciascuno con un proprio corredo di abilità specifiche, entreranno in scena con il prosieguo del racconto e saranno controllabili direttamente dal giocatore tramite un semplice clic nella porzione superiore dello schermo, mentre la parte inferiore è occupata dalle nove azioni eseguibili e dall’inventario nel quale alloggiano tutti i nostri possedimenti: è bene ricordare come l’approccio ideale per questo tipo di giochi incoraggi l’appropriazione, lecita o indebita, di qualunque oggetto che non sia inchiodato a terra, poiché non sappiamo se o quando ci tornerà utile… il pattume in eccesso può essere gettato negli appositi cestini disseminati per tutta la città ma, fedele ai principi del suo autore, il gioco non ci consentirà di scartare nulla di fondamentale per la risoluzione degli enigmi. Capita poi che questi ultimi richiedano la collaborazione di più attori, come d’altronde spiegato nel prologo, poiché il ritrovamento di uno specifico utensile non implica il possesso delle competenze necessarie per adoperarlo, dunque è un bene che l’interfaccia permetta di scambiare oggetti e interpreti con pochi passaggi di mouse (o di pad). La storia si intreccia con il presente, il passato e il futuro del paese e dei suoi caratteristici abitanti, procedendo con sapiente equilibrio lungo il sottile confine che separa l’intrigante ambiguità dalla follia demenziale, in maniera analoga a quanto Gilbert ha già fatto nel suo Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge: da quest’ultimo e, più in generale, dalla tradizione delle avventure grafiche pubblicate a cavallo degli anni ‘90, Thimbleweed Park eredita il senso dell’umorismo sottile e irriverente, spesso frutto dello studio accurato degli elementi di sfondo e dei dettagli solo in apparenza trascurabili piuttosto che dei dialoghi veri e propri, e la passione per lo sfondamento della metaforica parete che separa il giocatore dai suoi alter ego digitali, i quali si mostrano spesso consapevoli della realtà virtuale cui appartengono e ne danno abbondante riprova con una nutrita serie di battute autoreferenziali sul modus operandi della LucasArts dei bei tempi andati, sulle pretese spesso assurde che gli utenti erano costretti a soddisfare per proseguire (come la caccia agli elementi non più grandi di un singolo pixel, qui tradotta nel requisito per un obiettivo facoltativo) e sulla ricorrente diatriba fra retrogaming e produzioni moderne. I dialoghi di questo tipo sono sempre intriganti e mai spocchiosi, ma la loro abbondanza potrebbe venir percepita come un tentativo eccessivo di battere il ferro della nostalgia e tende a distogliere l’attenzione dall’esemplare riguardo infuso in ogni singola inquadratura. Per fortuna, i toni autoironici tendono ad attenuarsi non appena si entra nel vivo della faccenda, cedendo il passo ad un ricco assortimento di indovinelli che rievocano i momenti migliori del genere, opportunamente rivisti e corretti per evitare soluzioni fortuite o illogiche: beninteso, ci verrà comunque chiesto di compiere azioni o mescolare oggetti in modi tanto paradossali quanto esilaranti, ma sempre con un certo raziocinio di fondo che, al massimo, porta ad inveire bonariamente contro se stessi per non aver pensato prima ad una certa concatenazione di eventi, non contro il monitor per la stupidità di un ragionamento comprensibile soltanto ai programmatori. In effetti, esistono un paio di eccezioni piuttosto astruse che tuttavia servono da mera conferma alla regola, poiché la soddisfazione ricavata dalla soluzione di un determinato passaggio è sempre maggiore rispetto al tempo impiegato per analizzarne gli indizi.

VOLETE CHIUDERE QUESTO CASO-A-RINO?
Benché sia una discendente diretta dell’originale SCUMM, l’interfaccia grafica di Thimbleweed Park possiede una sfilza di facilitazioni che agevolano non poco la navigazione fra le schermate: anzitutto, la pressione del tasto TAB evidenzia i punti con cui è possibile interagire (con il pad o su console, i tasti dorsali ciclano direttamente sugli stessi), mentre il passaggio del cursore fa accendere il verbo più probabile da utilizzare, come “apri” per una porta o “parla” con un comprimario, che si può quindi richiamare con X o il tasto destro del mouse. Peccato che il sistema non funzioni sempre in maniera impeccabile, ed i personaggi tendano, fra le altre sviste, ad “esaminare” gli interruttori della luce piuttosto che “usarli”: i neofiti dovranno armarsi di pazienza e rassegnarsi a fare certe cose alla vecchia maniera con la magra consolazione, ma solo per chi usa un PC, di poter sfruttare qualche ulteriore scorciatoia via tastiera. A proposito dei meno avvezzi, all’avvio il gioco vi proporrà se scegliere un approccio “casual” oppure di affrontare la cosiddetta modalità “difficile”, ma il mio consiglio è quello di non lasciarvi trarre in inganno: la prima delle due opzioni infatti elimina intere sequenze e scene d’intermezzo, accorciando sensibilmente l’esperienza, laddove la seconda non presenta alcunché di troppo impegnativo ma è soltanto un po’ più articolata. A ben pensarci, sarebbe stato meglio lasciare inalterata la lunghezza dell’avventura e fornire piuttosto ai principianti la possibilità di ottenere suggerimenti effettivi sul da farsi.
Il comparto tecnico cattura alla perfezione l’estetica dei classici LucasArts, grazie ad un motore grafico ad hoc nato dall’unione di quello già realizzato da Gilbert in C++ per alcuni suoi precedenti lavori, come Scurvy Scallywags e The Big Big Castle!, più SDL, per la gestione degli input lato utente, e Squirrel, linguaggio di scripting progettato dall’italianissimo Alberto Demichelis. Parimenti, la colonna sonora contiene brani dall’impronta spiccatamente blues capaci di evocare ancora una volta l’immaginario figurativo dell’entroterra statunitense, opera di un impeccabile Steve Kirk che qualcuno ricorderà per le sonorità jazz di Voodoo Vince, da poco rimasterizzato per Xbox One e PC. L’affetto che tanto Gilbert quanto Winnick nutrono nei confronti dei loro fan si concretizza nella smisurata biblioteca di casa Edmund e nell’incredibile quantitativo di numeri riportati nell’elenco telefonico comunale: la prima contiene una raccolta di saggi brevi che i contribuenti hanno inviato e che trovano in questa sede una doverosa pubblicazione; il secondo, invece, riproduce i messaggi registrati da altri giocatori che variano dallo spassoso all’imbarazzante ma tutti, a modo loro e fuor d’ogni dubbio, bellissimi. Un modo originale per rendere omaggio a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo piccolo sogno, con la speranza che gli incassi mantengano saldo il sodalizio fra i due soci ritrovati e ci regalino altre perle della medesima caratura.