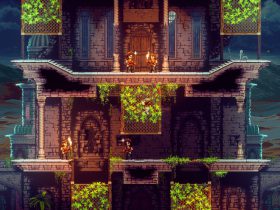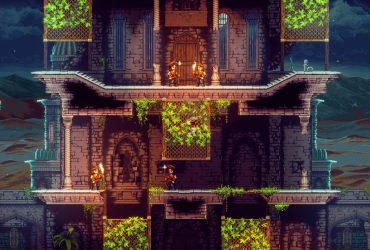Attenzione: le opinioni dell’autore non riflettono necessariamente quelle della redazione di GamesVillage.
Un giorno, nel lontanissimo 2001, un game designer di nome Fumito Ueda partorì un gioco destinato ad entrare nella storia, nel bene e nel male. Quel titolo prendeva il nome di ICO. Nei panni di uno sfortunato ragazzino imprigionato in un misterioso castello, il nostro compito era evadere dallo stesso, portando con se una ragazza di luce che prendeva il nome di Yorda. Il resto è storia nota ai più. ICO non verrà solo ricordato per alcune meccaniche di gioco particolari per gli elementari puzzle ambientali, ma anche e soprattutto per il fatto che si trattava del primo, vero, “videogioco poetico”. Vale a dire quella categoria di videogames, mai ufficializzata all’anagrafe, nel quale l’elemento emozionale sovrasta qualsiasi cosa. Incluso, spesso e volentieri, il gameplay stesso del titolo.
Negli anni a venire, a cavallo tra la generazione a 128 bit e la successiva, il mercato vide proliferare questo genere di “esperienze”. Basti pensare a Journey, titolo che “toccava le corde dell’emotività” senza però che le mani toccassero molto spesso i tasti del joypad: il titolo ci vedeva controllare un misterioso personaggio, dall’aspetto a metà strada tra un tuareg e un partecipante al ballo in maschera di Eyes Wide Shut, in cammino verso la cima di una montagna, per motivi che forse non ci è dato sapere. Due ore (questa la durata effettiva del gioco) nelle quali dovremo attraversare lande totalmente sperdute e desolate, saltellando di tanto in tanto e raccogliendo cose. E poi? E poi il nulla. La critica lo esaltò facile, gridando al capolavoro, estasiata dall’atmosfera soffusa e da tutta una serie di chiavi di lettura (molte delle quali, ben poco credibili) come una certa simbologia dell’aldilà ed il concetto di viaggio inteso come ricerca di se stessi. Tutto molto bello. Ma anche no. Giustificare un videogioco poverissimo sotto tutti gli aspetti definendolo senza troppi giri di parole come “poetico”, quasi fosse l’aggettivo salvagente per una certa categoria di prodotti assolutamente mediocri, è un modo di fare assolutamente improprio per analizzare il medium.
Quella categoria di videogames mai ufficializzata all’anagrafe, nel quale l’elemento emozionale sovrasta qualsiasi cosa
E poi, ancora: Flow (noto anche come flOw) di Jenova Chen e Nicholas Clark, un “balletto di microorganismi” che ha il suo successo di pubblico e critica ma che a conti fatti resta una gran bella sciocchezza. Passando infine per Flower, in cui si vestono i panni (se così possiamo dire) di un petalo sospinto dal vento, contro l’inquinamento della città che farà da sfondo alla nostra esperienza. Roba che Greenpeace sarebbe fiera di utilizzare per denunciare in maniera creativa i problemi ambientali. Un po’ come il concetto alla base del recente ABZÛ, da poco analizzato anche da queste parti (avete già letto la nostra recensione?): gli sviluppatori di Giant Squid Studios devono aver pensato che se proprio non ci si possono permettere le ferie al mare, tanto vale portare l’oceano nelle nostre case. Secondo voi ha senso, vero? Attenzione però: con questo discorso non sto assolutamente dicendo che il mercato dei videogiochi deve essere perennemente invaso dai Call of Duty di turno o dai FIFA e PES a cadenza annuale. Ben vengano le idee originali e particolari (dopotutto, parliamo di un medium in costante evoluzione), ma Vade retro Satana tutta quella serie di “videogiochi emotivi” con velleità creative che a conti fatti privano il videogioco delle sue fondamenta, nonché della regola base numero uno sin dai tempi di Pong: l’interazione. Perché a impersonare un petalo, un pesce o un’ameba, c’è sempre tempo. Anzi, ora che ci penso: no, grazie.