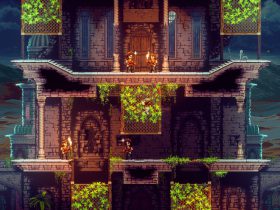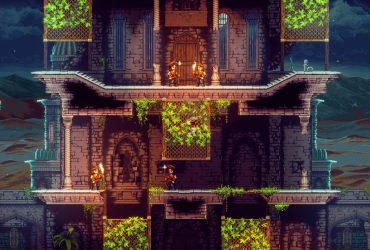Il disagio psicologico è un argomento che, come genere umano, ci accompagna da sempre, temuto, respinto, stigmatizzato, studiato, affrontato o cautamente evitato, fino a diventare un tabù. Il 13 di maggio cadevano quarant’anni dall’entrata in vigore della Legge 180, meglio conosciuta come “Legge Basaglia”, che aiutò a rinnovare completamente l’approccio e il metodo di cura delle cosiddette malattie mentali e la cui conseguenza più evidente fu la chiusura degli istituti di cura noti anche come manicomi.
Il Videogioco, medium coraggioso e curioso nello sperimentare continuamente nuovi approcci a una gamma sempre più ampia di temi, ha affrontato in modi fra loro molto diversi quello del disagio psicologico, della malattia e della follia. Vogliamo oggi parlare di questo. Nel suo testo pubblicato da Einaudi nel 1968 “L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico” Franco Basaglia afferma:
Noi neghiamo la disumanizzazione del malato come risultato ultimo della malattia, imputandone il livello di distruzione alle violenze dell’asilo, dell’istituto, delle sue mortificazioni e imposizioni; che ci rimandano poi alla violenza, alla prevaricazione, alle mortificazioni su cui si fonda il nostro sistema sociale.

E proprio questo approccio al malato mentale come persona che sta attraversando una “crisi” anziché come qualcosa di altro, di diverso, fu il motore per quello che nel tempo si sarebbe rivelato un cambiamento epocale nella considerazione e interazione con il disagio psicologico. Rivoluzionaria fu l’idea che il malato non fosse una sorta di oggetto dello scandalo da nascondere nei manicomi, lontano e ben separato dal resto della comunità bensì un individuo non dissimile da chi se ne prende cura, con la sua personalità, inclinazioni e aspirazioni, i medesimi bisogni e diritti.

Questo portò quindi Basaglia a teorizzare la “distruzione” dell’ospedale psichiatrico in quanto luogo chiuso che isola il malato e che ne determina l’oggettivazione e perdita di individualità, ribadendo per contro l’importanza dello “spazio aperto” e dell’interazione fra il malato e il mondo. Il diritto di una persona malata ad essere trattata come tale anziché come una fonte di imbarazzo, disagio e scandalo; diritto che ormai dovremmo dare per scontato ma che è in effetti figlio di un processo lungo e tortuoso.
Molti media si sono occupati della follia nelle sue innumerevoli manifestazioni, e il nostro Videogioco, come citato in apertura, non è da meno. A ricordarci quale fosse l’approccio alla malattia in anni ormai lontani nel nostro paese ci ha pensato uno sviluppatore italiano, LKA con la sua opera del 2016 The Town of Light. Il gioco ricrea al dettaglio l’istituto di cura della città di Volterra e in particolare il padiglione Charcot aggiunto insieme ad altri al corpo principale dell’ospedale a partire dal 1926. Certo, l’evoluzione della scienza medica in generale ci ricorda che, in passato, con l’intento di curare una persona spesso la si danneggiava pensando di fare il suo bene. Nella storia dell’ospedale di Volterra, ad esempio, si registrano i primi esperimenti di rendere il frenocomio un luogo operoso dove i malati venissero spronati alle attività lavorative più varie col fine di non lasciarli in balìa delle loro ossessioni.
Eppure, l’istituto faceva parte di una rete ospedaliera nazionale che, sempre con intenti curativi, usava regolarmente metodi che oggi non esiteremmo a definire torture come i bagni e le docce gelate o la terapia elettroconvulsivante senza anestesia. In quello che lo sviluppatore stesso paragona ad un romanzo storico con il desiderio di offrire una trama originale – quindi di fantasia – inserita però in un dato contesto storico ricreato con quanta più cura e verosimiglianza possibile, ci troviamo ad esplorare in un continuo andirivieni temporale il padiglione Charcot, ormai abbandonato e caduto in rovina ai giorni nostri, con numerosi salti indietro nel tempo al periodo dei primi anni Quaranta, quando quella porzione di ospedale era attiva e ospitava numerose degenti, fra cui la triste e sfortunata protagonista, la giovane Renée.
Si notano fin da subito emergere gli elementi propri dei frenocomi di un tempo già nel primo ricordo di Renée, quando la ragazza si rivede accompagnata per la prima volta davanti alla porta dell’ospedale:
Dissero che mi portavano in un posto dove la paura andava via, dove sarei stata meglio. Lì dentro ho smesso di vivere. Mi trascinarono via e mi strapparono ogni cosa di dosso, ogni cosa. Cercai di spiegare quello che mi succedeva; mi legarono al letto, per giorni, abbandonata ai miei incubi. Non era più paura la mia, era pazzia! E quando sei pazzo, non esisti più.
Da questo momento in avanti il giocatore accompagna Renée alla riscoperta della sua vicenda, fatta di violenze e abusi, di domande mai risposte, di dolore e paura e di qualche sorriso che, pur troppo debole per impedire la graduale morte del sé, almeno risveglia il ricordo della dolcezza e della capacità di amare, ultima e più preziosa risorsa dell’essere umano. Renée è una persona stritolata negli ingranaggi di un macchinario impietoso e inarrestabile che, per parafrasare Basaglia, si concentra così accanitamente sulla malattia da curare, al punto da tralasciare e finanche danneggiare il malato; la sua personalità, i suoi sogni, tutto ciò che la definiva prima di varcare le porte dell’ospedale le scivolano via dalle dita; e lei, rimasta ormai senza speranze, narra la sua triste storia con un fare pacato che spezza il cuore.
Al giocatore, inserito in un contesto storico così rispettosamente riprodotto, non resta che imparare, ricordare e riflettere: Renée è frutto di fantasia, ma quante Renée reali in tutto il mondo sono state private della loro personalità, dei loro sogni, confinate in stanze alla mercé dei propri disturbi e di chi le curava seguendo procedure mediche che spesso soffocavano i sintomi lasciando però segni ancora più profondi, sole, dimenticate da famigliari e amici? Quante Renée reali sono state vittime di violenze e noncuranza? E quante fra loro non erano pazze e hanno finito col diventarlo? I tempi sono cambiati, certamente. Eppure, esplorare quei corridoi e rivivere quei momenti, pur attraverso il filtro dello schermo davanti agli occhi e del pad tra le mani, ci aiuterà a ricordarcelo e magari a guardarci indietro e poi a guardare avanti con uno sguardo diverso.

Personalmente ritengo che The Town of Light sia un titolo illuminante e che possa veramente fungere da esempio per come un videogioco possa trattare efficacemente tematiche tanto delicate, senza per forza servirsi della follia come elemento per rendere più accattivante la meccanica di gioco. A tal proposito, ho avuto il grande piacere di poter intervistare Luca Dalcò, fondatore di LKA, lo sviluppatore che ha creato The Town of Light e che ci regala numerosi spunti su cui riflettere.
The Town of Light è nato in primis grazie all’ispirazione di un luogo reale, e cioè l’ex ospedale psichiatrico di Volterra ormai in disuso che, come lei ha giustamente sottolineato in una precedente intervista, poteva essere emblema della storia del manicomio in Italia e della sua evoluzione dagli anni Trenta fino ai Settanta. Come mai la scelta di rimanere al presente anziché ambientare l’intero gioco nel passato?
Molti manicomi, una volta terminata la loro funzione di “Ospedali Psichiatrici” a seguito della legge 180 del 1978, non sono stati più utilizzati, sono stati abbandonati all’azione graduale ed inesorabile dei vandali e del tempo. Oggi sono spesso poco più che ruderi parzialmente riconquistati dalla natura, ombre del loro controverso passato. Visitando queste strutture si sente immediatamente come siano la migliore rappresentazione possibile di se stesse. È come se il tempo avesse eroso lo strato di patina che rendeva queste strutture, quanto meno all’occhio, moderni complessi ospedalieri e ne abbia svelata la vera natura fatta di miseria, abbandono e disperazione. The Town of Light parte dal presente proprio per restituire questa immagine priva di veli, questa sensazione di esclusione. Nello svolgersi dell’esperienza l’ambiente è costantemente specchio dell’animo della protagonista e dell’istituzione e deve attivamente contribuire a comunicare, a raccontare.

The Town of Light è un titolo che tratta in maniera delicata e al contempo potente il tema del disagio psicologico e della distruzione della personalità. Renée è una ragazza che ci racconta di aver subito mille abusi e violenze, fuori e dentro il manicomio. Chi è in fondo Renée? Cosa vuole dire all’utente, qual è il suo messaggio ultimo?
Renée è una narratrice inaffidabile a causa dei suoi disturbi e lo sa, per questo il giocatore dovrà guidarla nella ricerca di una verità che non esiste. Esistono infatti molte verità e non sempre ce n’è una giusta e altre sbagliate. Dipende dall’angolazione da cui si guardano le cose, la stessa realtà può cambiare radicalmente se osservata da differenti punti di vista, è il caso della cartella clinica che racconta un’altra storia, altrettanto vera e, allo stesso tempo, altrettanto falsa. L’inaffidabilità dello sguardo clinico deriva da vari fattori: dai limiti di una scienza ancora giovane che poco o nulla capiva di ciò che succedeva ai malati psichiatrici ed elargiva terapie oggi considerate torture, dalla necessità dell’istituzione di tutelarsi e da quello che era il frutto della cultura e della società del tempo.
A volte mi chiedo come vedremo tra qualche decennio i nostri giorni, siamo sicuri che molti aspetti della nostra società non saranno considerati folli e inumani grazie al progresso, che nel frattempo, avrà permesso di vedere la realtà sotto differenti luci? Riuscire a vedere la stessa cosa da differenti angolazioni significa essere capaci di empatia, elemento essenziale che The Town of Light cerca di far sviluppare al giocatore nei confronti della sua protagonista. Se il giocatore non riesce a sviluppare questa empatia allora probabilmente odierà The Town of Light.
Uno dei punti chiave è cercare di trasmettere la sofferenza che deriva dal non poter contare su sé stessi. l’alternanza dell’uso della prima e della terza persona quando Renée parla di Renée cerca di rappresentare la grande difficoltà che la ragazza incontra nel relazionarsi con se stessa, scoprendosi a tratti incoerente, estranea o addirittura nemica.
Nel ripercorrere la sua storia, Renée è spesso fredda e distaccata. Questo non avviene solo per la rassegnazione, ma anche perché nel raccontare un trauma profondo e irrisolto il distacco è una difesa dal rivivere il trauma stesso. Renèe è viva, intelligente, sensibile e non cessa mai di esserlo, ma Renée è sempre più lontana fino a non essere più raggiungibile dall’esterno e a non essere più in grado di raggiungere l’esterno.
Il continuo bisogno di difendersi, sia dalla malattia che dall’istituzione, la spingono ad erigere barriere sempre più resistenti, barriere impenetrabili che la isolano, smarrita, in un sistema comandato dalle sue paure. Cito una frase di Renée: “La realtà per me era come uno specchio attraverso cui guardare il mondo, improvvisamente frantumato in mille schegge affilate. Non ero più in grado di muovermi senza ferirmi, stavo ferma, erano le cose che mi si avvicinavano, mi si arrampicavano addosso e mi soffocavano”.

Sempre in un’intervista precedente lei ha paragonato The Town of Light a un romanzo storico, sottolineando l’elemento di finzione. Come mai optare per un personaggio fittizio, anziché proporre l’esperienza di un internato realmente esistito?
Renée è un simbolo, rappresenta la vita negata alle centinaia di migliaia di persone che abitarono i manicomi. Non poteva essere la protagonista reale di una delle tante storie in cui mi sono imbattuto nel percorso di ricerca che ha portato alla scrittura della storia di “The Town of Light”, ma piuttosto un simbolo che racchiudesse in sé molte storie cogliendone gli elementi comuni.
Nel gioco sono presenti scene dall’impatto emotivo molto forte, in cui vengono riprodotti i metodi contenitivi dell’epoca. Quali emozioni vi ha procurato il ricreare scene del genere, considerando che all’epoca quella era la prassi per il trattamento dei malati?
Le terapie che venivano usate prima dell’arrivo della clorpromazina appaiono oggi folli. L’avvento degli psicofarmaci ha operato un cambio di percezione nei confronti di quanto, fino allora, era normalmente accettato. L’impotenza terapeutica nei confronti dei malati era quasi totale e le uniche terapie che sembravano avere qualche effetto erano le terapie da shock. Probabilmente se ne sarà abusato, ma in tante situazioni la scelta era tra una terapia aggressiva ed una sofferenza terribile, senza fine. Non parlo tanto dell’elettroshock, che è tutt’oggi in uso (con l’anestesia) e talvolta unica possibile terapia nella depressione per attenuare la sofferenza nei casi in cui la terapia farmacologica si riveli inefficace.

Parlo piuttosto di insulinoterapia, terapia con cardiazol, malarioterapia, tutti metodi violenti, invasivi e pericolosi che inducevano convulsioni nel paziente permettendo la regressione temporanea dei sintomi. Oltre all’impotenza terapeutica occorre sapere che il personale che operava nei manicomi era molto ridotto rispetto al numero di pazienti e questo si traduceva in una assistenza medica non continuativa (1 medico seguiva centinaia di pazienti) e nell’uso di metodi contenitivi oggi percepiti come abusi e torture. I pazienti venivano legati al letto per giorni, legati ai termosifoni, picchiati, infilati sotto docce gelate, soffocati con un panno bagnato, legati con le camicie di forza.
È terribile, Provate però a pensare ad una manciata di infermieri che dovevano gestire 2 o 300 pazienti agitati, cos’altro potevano fare? È stato facile cambiare modo di vedere le cose dopo l’avvento della clorpromazina che chimicamente, in modo più asettico e pulito allo sguardo dell’osservatore, calmava il paziente rendendolo inoffensivo. Era nota come “lobotomia chimica”. Queste considerazioni non vogliono certo giustificare quello che è stato, solo mettere in evidenza che il manicomio non è stato frutto di sadismo compiaciuto, ma il risultato di una combinazione di impotenza, inadeguatezza in una cultura che considerava il malato di mente come un diverso appartenente ad una categoria umana inferiore.
Proprio questo aspetto ha causato le emozioni più forti nella scoperta del manicomio. Quando c’è un cattivo tutto è più semplice. Innanzitutto basta far fuori il cattivo e tutto si risolve, in secondo luogo tutte le frustrazioni causate dalla crudeltà della storia possono essere focalizzate sul cattivo. Se il cattivo non c’è le cose peggiorano, si rimane basiti di fronte al prodotto della società, di gente che agiva in buona fede, animata da ideali largamente condivisi.
La gente ci metteva i propri figli nei manicomi, i propri cari. Si pensava fosse l’unica soluzione, il male minore.

Renée è stata guarita dall’asilo e poi dallo stesso stritolata e divorata. È ancora una volta l’esempio di numerose vite perse per strada, prigioniere della divisione forzata fra malati e resto del mondo?
Hai colto perfettamente quello che volevo comunicare. È un paradosso fondamentale che a mio avviso appartiene a tutte le istituzioni totali. Anche quando l’istituzione riesce nel suo scopo primario, ovvero nello specifico dei manicomi, attenuare la sintomatologia, nello stesso momento fallisce con l’individuo, isolandolo, stigmatizzandolo, alienandolo e disindividualizzandolo. L’individuo rimane solo e l’unico suo mondo possibile è l’istituzione stessa.
Credo che questo concetto non sia una caratteristica specifica del Manicomio, ma di tutte le istituzioni totali, una che è evidentemente imbrigliata negli stessi meccanismi è il carcere, come dimostra con chiarezza disarmante il modello norvegese. La società, però, accetta queste istituzione, anzi, quando si sente in pericolo ne richiede un inasprimento, anche al di là della logica e dell’evidenza.
Fino a quando qualcuno o qualcosa riesce a far cambiare punto di vista riabilitando l’umanità delle vittime dell’istituzione, a questo punto la società stessa inizia a considerare soluzioni alternative e più utili. Per adottare queste soluzioni ci vuole coraggio, così come, in generale, ci vuole coraggio per progredire, perché spesso progredire vuol dire mettere in discussione se stessi e le proprie convinzioni.

La narrazione di una storia personale agghiacciante e terribile ci ha consegnato, anziché una “matta”, una ragazza con i suoi timori e le sue emozioni. Mi sembra che, parlandone così senza timori, The Town of Light voglia, o comunque riesca a lanciare il messaggio che un disturbo psicologico non debba coincidere con una condanna. Conferma questa impressione?
Confermo senza dubbio. Uno degli obiettivi di The Town of Light è, per quanto possibile per un piccolo titolo indipendente, quello di cercare di combattere lo stigma che, ancora oggi, aleggia sulla malattia mentale e più in generale sul disagio psichico. Cerchiamo di ottenere questo risultato lavorando sull’empatia che il giocatore sviluppa con la protagonista. “Empatia” è la parola chiave. Quando riusciamo a vedere con gli occhi dell’altro possiamo capirne le emozioni, le sensazioni, le ragioni, percepirne l’umanità.
Una fetta enorme della popolazione è coinvolta con problematiche di questa natura. Leggere forme di depressione e/o ansia colpiscono quasi la metà della popolazione, forme più severe delle stesse sono comunque estremamente diffuse. Le statistiche sull’uso degli psicofarmaci ci mostrano con chiarezza la portata del problema. Non si deve mai smettere di lavorare ad un percorso di accettazione e destigmatizzazione. Un passo enorme fu fatto negli anni della riforma psichiatrica, ma la strada da percorrere è ancora lunghissima. La malattia mentale, come tutte le cose terribili che sentiamo vicine, ci spaventa, ma allo stesso momento, per conseguenza, ci affascina. Questo fascino si traduce spesso in un uso del tema molto lontano dalla sua reale natura. Nelle produzioni cinematografiche, letterarie e videoludiche il disagio psichico è molto presente, ma spesso è usato come escamotage per raccontare storie che con il disagio hanno poco a che vedere. Ci viene ad esempio presentato il matto assassino seriale senza pietà, oppure genio ribelle.
Molto più di rado il disagio viene presentato per quel che principalmente è, ovvero sofferenza. Nulla di strano in tutto questo, non si tratta certo di un caso unico, basta pensare a come la guerra sia oggetto di prodotti destinati a divertire! In fondo dissacrare è un modo di esorcizzare, ma se queste operazioni di “catarsi” non sono affiancate da prodotti che ci riportano alla cruda e crudele realtà con un pugno nello stomaco, allora rischiamo di aggravare lo stigma e di banalizzare, di creare indifferenza.

L’esperienza di The Town of Light dimostra chiaramente come il videogioco sia un medium che si presta alla trattazione di temi seri e delicati. Quali sono le caratteristiche che fanno in modo che The Town of Light si esprima meglio come videogioco piuttosto che come film o documentario?
Non saprei dire se un videogioco possa essere più o meno efficace di un film nel raccontare una storia drammatica. Ci sono delle evidenti differenze tra i due linguaggi, così come anche delle similitudini. Credo che il gioco si presti bene a mettere il giocatore nei panni della protagonista. Vedrà con i suo occhi in modo attivo, partecipe, muoverà i suoi passi, sentirà i suoi pensieri in base alle proprie azioni, rievocherà i suoi ricordi attraverso scelte e parteciperà alla sua confusione faticando, egli stesso, a ricostruire i fatti ed aiutandola a trovare la strada. Questo credo sia un buon modo per sviluppare empatia, per sentirsi sempre più vicini alla protagonista e viverne il dramma quasi sulla propria pelle.
Si parla ultimamente della possibilità di cercare un termine diverso da “videogioco” per riferirsi ad esperienze interattive come questa. Se le chiedessi di usare un termine che non fosse “giocare” per riferirsi a fare una partita con The Town of Light, lei che termine sceglierebbe?
Il termine inglese “Play” si presta perfettamente perché vuol dire giocare, interpretare, suonare, riprodurre, spettacolo. La traduzione italiana “giocare” è molto restrittiva e si presta solo ad una fetta di prodotti videoludici. Tra le possibili traduzioni di play, per The Town of Light, userei “interpretare” nel senso ruolistico del termine. L’esperienza sta nel calarsi nei panni di qualcuno e vivere la sua esperienza, ovvero interpretare quel ruolo.
Una ulteriore considerazione: Mi piacerebbe avere dei termini alternativi alla parola “videogioco” stessa, qui anche la lingua inglese cade! Ma non saprei cosa proporre oltre a orrori tipo “Applicazione multimediale interattiva”… meglio videogame, non c’è ombra di dubbio! Accettando Vidogioco per mancanza di alternative, mi accontenterei di non essere costretto ad inquadrare The Town of Light nel genere “avventura” che è quello tra i generi universalmente riconosciuti nei videogiochi che gli si avvicina di più. Perché non esiste il genere “drammatico”? Nel cinema esiste ed è uno dei generi che conta più titoli e successi, perché nei videogiochi non esiste? Onestamente non riesco a spiegarmelo.

È un titolo onesto, The Town of Light. Un titolo che, come avete capito dalle parole di Dalcò, racconta fedelmente uno spaccato di mondo che adesso non c’è più, non in quella forma, ma che quando esisteva era l’unica risposta ai disturbi psicologici. Non si limita a raccontare, ma ci fa vedere attraverso gli occhi di Renée la sua storia, perché ne percepiamo intatta l’umanità, così potente che la persona arriva all’utente prima, molto prima del “matto” che questa rappresenta per chi è intorno a lei.
La possibilità di camminare un bel pezzo di strada nelle scarpe di Renée ci permette di avvicinarci a lei lasciando fuori dubbi, timori e pregiudizi. Proprio la potenza immersiva del videogioco rende la narrazione unica in quanto direttamente esperibile, finanche manipolabile. Ed è esattamente questo tratto del medium che forse potrebbe renderlo adatto alla divulgazione di un tema come quello in oggetto. Pensando all’enorme diffusione delle macchine da gioco e dei computer nelle nostre case e la dimestichezza con cui anche le generazioni più giovani vi si rapportano, parrebbe consequenziale sfruttare la potenzialità del videogioco per iniziative costruttive e formative.
Ci siamo concentrati su The Town of Light che per le sue modalità narrative si qualifica come un titolo validissimo per trattare una tematica tanto forte in maniera che, pur riuscendo ad incuriosire l’utente a livello di trama ed esplorazione, non fa della follia un elemento puramente ludico.
Tuttavia, non è la prima volta che la malattia mentale viene trattata nei videogiochi, e con modalità anche molto diverse, come sottolinea anche Dalcò nella nostra intervista; solo per citare alcuni esempi, l’apprezzato Eternal Darkness ad opera di Silicon Knights del 2002 proponeva la travagliata vicenda di diversi personaggi distribuiti in epoche e spazi geografici diversi che si trovavano ad avere a che fare con situazioni che un po’ per volta li avrebbero fatti impazzire, forte di quell’impronta tipicamente lovecraftiana nella cui ottica il confronto con l’orrore da sé basta per infettare e consumare senza soluzione anche le menti più brillanti. Il gioco presentava nell’interfaccia addirittura una barra di misurazione della salute mentale dei personaggi, che consumandosi li vedeva costretti a sopportare allucinazioni sempre più scioccanti. In questo caso, la follia diventava elemento di gameplay, integrandosi nell’azione di gioco.
 Mi sono dedicata personalmente all’analisi di come il disagio psicologico sia stato implementato in un’altra esperienza interattiva mai dimenticata, il celebre Silent Hill 2 di Konami del 2001. Insistendo sull’analisi del comportamento del protagonista James Sunderland in stretta correlazione con gli elementi della città di Silent Hill, i suoi mostri e le sue alterazioni è possibile riscontrare gravi disturbi nella personalità in James. Ancora una volta questi elementi si integrano perfettamente nel gameplay e nella narrazione, pur in maniera meno evidente, più sottile rispetto all’esempio precedente. Le paranoie e le ossessioni di un uomo distrutto da un lutto e gravato dal peso di una colpa dimenticata plasmano l’avventura accompagnando protagonista e utente fino alla fine.
Mi sono dedicata personalmente all’analisi di come il disagio psicologico sia stato implementato in un’altra esperienza interattiva mai dimenticata, il celebre Silent Hill 2 di Konami del 2001. Insistendo sull’analisi del comportamento del protagonista James Sunderland in stretta correlazione con gli elementi della città di Silent Hill, i suoi mostri e le sue alterazioni è possibile riscontrare gravi disturbi nella personalità in James. Ancora una volta questi elementi si integrano perfettamente nel gameplay e nella narrazione, pur in maniera meno evidente, più sottile rispetto all’esempio precedente. Le paranoie e le ossessioni di un uomo distrutto da un lutto e gravato dal peso di una colpa dimenticata plasmano l’avventura accompagnando protagonista e utente fino alla fine.
Più recente invece la trattazione del disagio psicologico nell’acclamato Hellblade: Senhua Sacrifice che molti riconoscimenti ha vinto proprio grazie alla sua eroina, la giovane Senhua caduta purtroppo vittima di gravi disturbi post-traumatici. Per la creazione della sua protagonista il developer si è servito della consulenza di uno psichiatra.

Il disagio psicologico, il peso delle scelte etiche, la narrazione di eventi reali e tremendi come il racconto di una terribile malattia che si porta via il nostro bambino (That Dragon, Cancer ad opera di Numinous Games del 2016 che narra una storia vera), la tragedia della guerra sulla pelle di chi non la combatte ma la subisce (This War of Mine di 11bit Studios del 2014), le sciagure della nostra Storia che il tempo finisce con la sua pazienza per far dimenticare quasi a tutti (Project Ustica), fino ad arrivare alle tematiche di divisione ed esclusione, di definizione del sé, della natura dell’essere umano e dei suoi diritti, tinte di fondo di Detroit: Become Human di Quantic Dream. La natura sperimentale, curiosa, mai sazia del Videogioco lo rende un medium che può davvero trattare ogni tipo di tematica e lo può fare con una potenza innegabile, forte del suo tratto caratteristico, l’interazione che costringe l’utente a immergersi nell’esperienza.
E non a caso, come accennavamo in precedenza nell’intervista con Luca Dalcò, si inizia a discutere di quella che sembra stia pian piano diventando una necessità e cioè iniziare a pensare a una nuova terminologia, a una nuova nomenclatura per il videogioco – termine che col passare del tempo ormai sembra non poter più contenere le numerosissime e sempre più profonde, serie, umane sfaccettature che lo compongono. In certi casi, “giocare” non è il termine adatto per definire quello che stiamo facendo: forse “esperire”, “imparare”, “ricordare”, “riflettere”, “interpretare” come giustamente Dalcò suggerisce sarebbero termini più adatti da utilizzare in riferimento a determinate opere multimediali interattive. Voi cosa ne pensate? Vedete nel videogioco un potenziale per spaziare anche largamente al di là dell’intrattenimento?