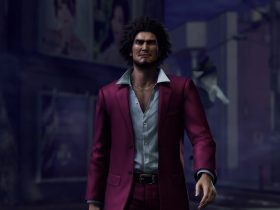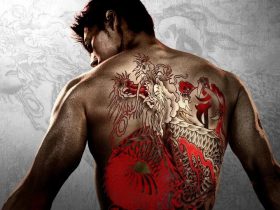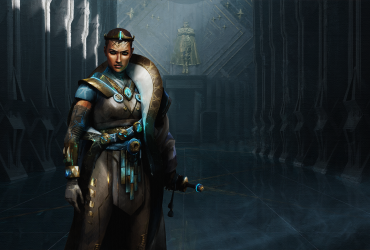C’era una volta, in un periodo storico non troppo distante da quello attuale, una società in cui si credeva che giocare fosse solo una perdita di tempo, un’attività inutile, un pretesto per allontanarsi dai libri di scuola e dai propri doveri. Quella società non è così diversa dalla nostra, se a un generico “gioco” sostituiamo il videogioco, con le sue potenziali problematiche legate ai danni psico-sociali che può causare. Ebbene, se certe concezioni e pregiudizi talvolta sono difficili da scalzare e non cambiano, diversa è la situazione per quanto riguarda l’avvicinamento tra gioco ed educazione. Anche in Italia.
C’è “gioco” e “gioco”
Le parole hanno un significato ben preciso e siamo proprio nel caso in cui questo concetto debba essere ben soppesato. A partire dalla distinzione semantica che traccia un solco a malapena visibile tra il concetto di ludus e paidia, modernamente declinati nei termini inglesi play e game, abbiamo la chiara separazione del “gioco” in due categorie, così banalmente distinguibili: a scopo di puro divertimento da un lato, a fini di edutainment dall’altro, ossia imparare divertendosi. Il fatto che la lingua italiana sia esente da terminologie specifiche per creare una linea di confine sottile, ma netta, non giustifica il nostro popolo dal non riconoscimento di questa doppia dimensione del gioco, adagiandoci passivamente sul principale significato della parola “gioco”. Non dobbiamo solo pensare a giochi realizzati a partire dai principi della scuola di Maria Montessori, ma anche a progressi molto più recenti, dove la dimensione videoludica non ne è priva. Da qui deriva una produzione sempre più numerosa e frequente di giochi a scopo educativo e istruttivo, una buona abitudine anch’essa identificata da un termine inglese: gamification. Nata dalla fusione di game e education, si tratta di una pratica adottata da aziende e applicata da alcuni team di sviluppo nei propri giochi, per ingaggiare e divertire sì, ma veicolando un chiaro contenuto istruttivo. Sicuramente vi sarete già imbattuti in progetti di questo tipo, non sono più una vera e propria novità, ma rimangono pur sempre una produzione di nicchia. Un motivo in più per approfondire la questione da vicino.
Un’immagine tratta da Semaland, un esempio di gamification del team Melazeta
L’insegnamento gaming all’italiana
E in Italia cosa succede? La voce di alcune piccole, grandi realtà si fa sempre più sentire, per quanto possa sembrare soffocata dai molteplici titoli che costantemente fanno capolino in questo settore. Anche all’ultima edizione di Milan Games Week è stato possibile scambiare quattro chiacchiere con i membri di Melazeta, il team che ha dato i natali a diversi progetti educativi esplorando diversi ambiti, a partire da WunderBO, la piattaforma mobile che consente agli utenti di esplorare Bologna e le sue bellezze culturali migrando dall’esperienza digitale all’incontro vero e proprio con i musei e alcuni centri culturali della città. Nasce da una collaborazione tra il Comune di Bologna, Bologna Musei e il Sistema Museale di Ateneo, a riprova delle radici immerse in toto in un hummus davvero impregnato di bellezza culturale tutta italiana, con l’obiettivo di condurre gli utenti alla scoperta delle origini del patrimonio che abbiamo a disposizione. WunderBO non è il solo lavoro del team, che ha dedicato le sue fatiche a progetti dove la contaminazione tra educazione e gioco si fanno sentire prepotenti in Semaland, una produzione pensata per i piccoli utenti, parte di una generazione ormai nata con gli smart device tra le mani e offrire loro delle esperienze di apprendimento attraverso serie TV, contenuti digitali, editoria e app di gioco ed edutainment. L’importanza e la crucialità di questo tipo di lavoro risiede non solo nei contenuti, ma nella precocità del target, sintomo di una generazione che cambia e che si incontra online fin dai primissimi anni di vita, fondamentali per porre le basi di crescita e sviluppo. Succede così che fioriscono le applicazioni educative, anche per i popoli oltre confine, come insegna il team a capo di Francesco Cavallari, Video Games Without Borders. Con la serie Antura, le colonne d’Ercole della gamification a sfondo educativo in Italia e all’estero sono state spostate un po’ più in là proprio in virtù dei meccanismi e delle regole che impostano la serie di giochi in questione. la sensibilità che sta alla base di questo progetto è figlia del mondo in cui viviamo, dove le nuove generazioni sono sempre più rivolte e attratte dalla tecnologia, diventa quindi insieme mezzo e veicolo di nuove informazioni e apprendimenti (se sfruttato in maniera consona, positiva e soprattutto funzionale all’insegnamento).
Uno screenshot di Father and Son, l’esempio italiano di gamification di Tuomuseo
Parola d’ordine: insegnare
Un’attività che sembra sempre più difficile, quella dell’insegnamento, per via di una commistione di fattori dalle origini più disparate, che collaborano tutti a a renderla sempre più distante dalla sua forma classica e tradizionale, per avvicinarla ha un funzionamento sempre più interattivo, proprio anche in virtù dell’introduzione sempre maggiore della tecnologia. Circa quest’ultima, uno dei principali luoghi comuni vede un attaccamento a device e console videoludiche inversamente proporzionale all’interesse che i fruitori di questi mezzi dedicano ad attività culturali offline, o comunque sul territorio. Inutile dire che, come ogni presa di posizione estrema, c’è sempre il rovescio della medaglia e la dimostrazione che si possa spezzare una lancia a favore del (video)gioco anche in questo settore. Oltre agli esempi sopracitati, non possiamo chiudere gli occhi di fronte ad associazioni del calibro di TuoMuseo, leader a livello mondiale nell’utilizzo di gaming e gamification a favore della promozione del patrimonio culturale. Guidato da Fabio Viola, considerato tra i migliori 10 gamification designer al mondo nella graduatoria stilata da RISE, il team internazionale a cui è a capo ha sviluppato diversi giochi a sfondo culturale e sociale, come Father and Son, forte di oltre 4 milioni di download, e volto alla promozione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il gioco ci conduce infatti alla conoscenza della storia dell’ultimo giorno di Pompei prima dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.c., oltre che avvicinare il giocatore alla vita quotidiana nell’Antico Egitto. Questo non è il solo caso di produzione di Tuomuseo: l’avvicinamento non solo alla cultura, ma anche alla conoscenza del patrimonio artistico e storico italiano, avviene attraverso A life in music, un’avventura grafica ambientata nella città di Parma con elementi di rhythm game e realizzato per il Teatro Regio di Parma e per Festival Verdi. Si tratta del primo gioco dedicato a un teatro d’opera e incentrato sulla storia due giovani musicisti, le cui vicende si incrociano con la vita di Giuseppe Verdi.
Si moltiplicano le occasioni per incontrare la storia italiana, non solo sui libri, non solo durante “noiose” lezioni frontali uno-a-molti: il gioco, e a maggior ragione il “videogioco”, diventa momento e motivo di incontro per amplificare e dare un più ampio respiro alla cultura. Chi l’ha detto che si studia solo sui libri, che si perde tempo videogiocando e che l’Italia è passiva e priva di progetti innovativi? Stereotipi da scalzare hic et nunc, alla volta di esperimenti che meritano sempre maggiore attenzione e che sono sintomo e manifestazione di un mondo attivo e di team reattivi, sensibili e attenti all’evoluzione contemporanea di una società che non sa fermarsi e alla quale, per certi aspetti, è bene adattarsi senza dimenticare i valori tradizionali e la buona educazione.